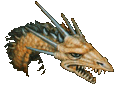
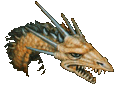
Rispetto alle altre operedella tetralogia, il testo del "Siegfried" è dominato dal ricorso massiccio all'immaginario mitologico e da uno scioglimento positivo. Il "Siegfried" vede un'evoluzione felice per il protagonista, che sul piano dell'azione e dell'amore conquista vittorie esaltanti: uccide il drago Fafner ed ottiene Brunnhilde.
Anche in questo caso si possono indicare le fonti precise per la vicenda in generale e per i singoli episodi (cioè l'epica soprattutto dell'Edda antica, e poi dell'Edda nuova e della Wolsungasaga), ma sorprende la frequenza di episodi, scenari, immagini, che appartengono al repertorio universale del mito solare dell'eroe, e più in particolare della sua giovinezza e formazione.
Siegfried appare dotato di superiori qualità fisiche e di un carattere schietto e semplice, dove la purezza morale è inficiata da una pericolosa inesperienza. Non a caso gli sta vicino Mime, che gli è specularmente opposto: un nano grottesco, la cui bruttezza fisica è parallela alla deformità morale. Nel primo atto due sono gli elementi mitologici più vistosi: la ricerca delle origini e la forgiatura della spada.
Nel mito dell'eroe la nascita appare come eccezionale e misteriosa: sovente rimane orfano, talora abbandonato e raccolto per avventura da qualche personaggio, cresce poi preparandosi a un'esistenza diversa, con indizi premonitori di un destino straordinario.
Nel primo atto questo è il tema conduttore, che sfocia nell'altisonante finale della forgiatura della spada. L'arma che Siegfried ha invano richiesto con insistenza a Mime, sarà quella che egli stesso riuscirà a plasmarsi, ricomponendo i frammenti di quella spezzata a suo padre: il giovane comincia quindi a scoprire la sua provenienza e insieme il mezzo per attingere all'eroismo. Da notare la frequenza simbolica degli episodi: Siegfried manifesta la sua forza con la cattura dell'orso, narra di essersi mirato nello specchio d'acqua come allegoria della ricerca di sé, infine è in grado di costruirsi lo strumento decisivo. Nel mito infatti l'arma appare attributo essenziale dell'eroe, che è tale solo in quanto dedito a imprese sublimi: nei poemi classici la descrizione delle armi dell'eroe, forgiate per di più dagli stessi dei, quindi con poteri magici, occupava spazi canonicamente significativi.
L'immagine conclusiva di Siegfried, che brandisce in alto Notung, è l'emblema di un eroe finalmente investito dalla sua suprema visione.
Il secondo atto è incentrato sulla lotta col drago. Wotan ha rivelato a Mime che solo un eroe senza paura può sconfiggere il mostro Fafner, padrone dell'Oro del Reno.
Il duello con il drago appare in tutte le mitologie, da quella greca a quella cristiana, e sta indicare lo scontro fra la dismisura propria del mostro che incute una paura ancestrale e la forza coraggiosa e razionale dell'eroe, che affronta un ostacolo insormontabile per l'uomo comune, conquistando un trionfo fondamentale per lui, ma anche per la comunità o la stirpe di appartenenza. Il contatto con il sangue del drago conferisce all'eroe un dono miracoloso: la capacità immediata di comprendere rettamente tutto ciò che gli comunica il mondo circostante, sia il linguaggio della natura, e quindi la voce del volatile che lo consiglia e lo guida verso Brunnhilde, sia la demistificazione della menzogna, e quindi le intenzioni maligne di Mime, che vorrebbe ingannarlo ma viene invece inteso secondo verità e quindi ucciso.
Anche la parte grottesca rappresentata dalla figura di Mime non è assente dall'epica tradizionale, perchè comunque indica la bassezza di cui l'eroe è esente, funge insomma da contrasto.
All'eroe tocca il premio per l'impresa compiuta, che sarà la bella addormentatta, cioè Brunnhilde. E anche nell'ultimo atto abbonda la simbologia eroica: prima Siegfried deve superarae l'ultimo ostacolo, più rituale che sostanziale, dall'incontro con il dio, cioè Wotan, che cede il passo al giovane cui egli stesso ha affidato la rigenerazione globale, sanzionando così una trasmissione di potere; poi il protagonista sale verso l'alto e oltrepassa la cortina di fuoco, in un percorso anche allegorico, interpretabile secondo l'idea di un'elevazione spirituale del soggetto. E gli stessi gesti di sciogliere le armi che rinserrano il corpo di Brunnhilde, e di svegliarla con il bacio, acquistano un valore pregnante, visto che Siegfried aveva prima brandito la spada Notung per incarnare il ruolo dell'eroe e ora toglie le armi di difesa alla Walkiria per eliminare ogni separazione e consentirle la rinascita come donna. Di fronte alla donna l'eroe viene seguito nella trepidante scoperta di qualcosa di sconosciuto: quell'elemento femminile così misterioso da suscitare persino una paura mai provata, neppure davanti al drago; una paura nel significato positivo di sensazione profonda, per una novità perturbante che prende totalmente il soggetto e scuote i meandri più reconditi dell'interiorità.
L'amore è visto da Wagner come una passione assoluta, come perdita di sé, annegamento nel gorgo di un'unione che travolge ogni limite; il finale dell'opera è infatti positivo, con la celebrazione del trionfo dell'amore, ma l'ultima parola cantata da Siegfried è "Tod", cioè morte.
Da ricordare la presenza di Wotan, che risponde all'archetipo del vecchio saggio, ma viene strumentalizzato da Wagner per altri più sottili discorsi: gli enigmi e le sentenze, le meditazioni sul destino, il dialogo filosofico con la madre terra Erda, in generale il suo linguaggio criptico, fanno teatralmente del dio padre il portavoce più autentico dei significati profondi ed inquitanti dell'opera, perchè, anche in una giornata così solare, deve trapelare la componente problematica, che è il vero marchio di quella riattualizzazione critica del mito operata da Wagner nel tetralogia.